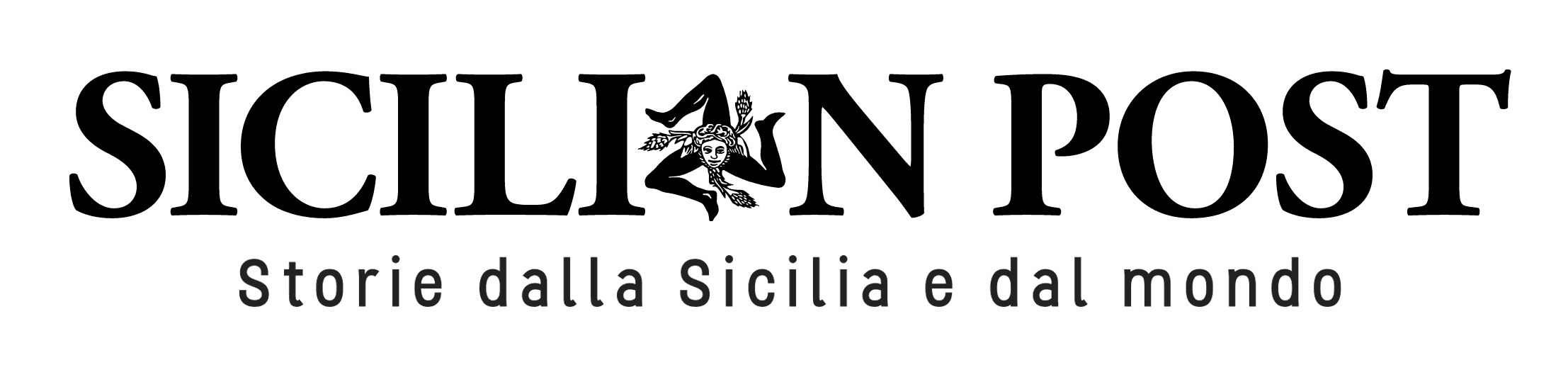Riccardo Noury: «Speranza per Zaki ma per i diritti umani c’è ancora molto da fare»
Dal 1° Febbraio Patrick Zaki – lo studente egiziano detenuto per 22 mesi in Egitto per aver difeso i diritti umani nel Paese – è diventato un cittadino onorario di Termini Imerese, in provincia di Palermo. La sua è una storia corale, scritta da tante donne e uomini che da quel 7 febbraio 2020 non l’hanno mai lasciato solo. Ne abbiamo discusso con Riccardo Noury, giornalista, blogger e portavoce di Amnesty International Italia, che da anni si batte affinché i diritti umani vengano rispettati in ogni parte del mondo.
A cosa attribuisce l’enorme mobilitazione per Patrick anche da territori, come la Sicilia, che apparentemente non hanno alcun legame con la vicenda?
«Credo ci sia stato un processo di identificazione di tanti ragazzi e ragazze che considerano Patrick uno di loro: uno studente entusiasta e curioso, che ha voluto fare un’esperienza all’estero per cercare un futuro, in una città come Bologna che è simbolo della libertà accademica, della solidarietà e dell’impegno civile. Da Bologna è come se fosse stato lanciato un sassolino in uno stagno che ha fatto una serie di giri concentrici sempre più ampi coinvolgendo l’Italia intera e non solo. Un esempio tra i più evidenti di questa solidarietà nazionale è, per l’appunto, il conferimento della cittadinanza onoraria da parte di tantissimi enti locali. Termini Imerese è tra gli ultimi, ma ce ne sono stati tanti altri in Sicilia. È una campagna che è nata dal basso coinvolgendo tanti attori e poi è arrivata lì dove si prendono decisioni sul piano diplomatico. Se Patrick oggi gode di questa situazione di libertà, sebbene provvisoria, è perché questa campagna ha visto tutti quelli che dovevano fare qualcosa, farla nel modo migliore».
Come sta Patrick e cosa succederà adesso?
«Dal 7 dicembre, giorno in cui è stata disposta la libertà provvisoria, abbiamo sempre detto che non era finita e che non dovevamo accontentarci. Patrick adesso sta riassaporando la libertà con grande entusiasmo, gettandosi a capofitto nello studio. Sta bene ma dobbiamo rispettare una serie di cose, in primis il suo stato d’animo non del tutto sereno a causa dell’udienza che ci sarà 6 aprile, in un processo che si svolge davanti a un tribunale d’emergenza le cui sentenze non sono appellabili».
Cos’è il sistema del “riciclo dei casi” (in arabo “Tadweer) messo in atto dal regime egiziano? Patrick ne è al sicuro in questo momento?
«Si tratta di una strategia del sistema giudiziario egiziano che consiste nel far sì che la detenzione senza processo si perpetui a tempo potenzialmente indeterminato, così da togliere dalla circolazione esponenti della società civile, difensori dei diritti umani, ricercatori, giornalisti, avvocati. Ricordiamoci che Patrick è stato messo sotto accusa per cinque diverse imputazioni. Una di queste è all’esame del giudice di Mansoura, mentre le altre quattro non sono ancora state annullate. Stanno lì che pendono. La nostra speranza è che non vengano riattivate, che questa vicenda abbia fine al più presto e che Patrick venga messo al riparo da quel meccanismo del quale sono vittime in tanti. L’unico modo è che venga in Italia».
Non si può parlare d’Egitto senza pensare a Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato ed ucciso nel gennaio 2016 al Cairo. Il 14 agosto 2017 veniva annunciato il rientro al Cairo dell’ambasciatore italiano, che era stato ritirato l’anno prima come forma di protesta per la scarsa collaborazione egiziana nelle indagini. La decisione venne presentata da vari esponenti politici come frutto di una nuova intesa tra governo italiano ed egiziano e con la promessa che la procura egiziana avrebbe inviato i video della metropolitana, ultimo luogo in cui Giulio venne visto prima della scomparsa. Cosa è successo in questi 5 anni? Quella promessa è stata mantenuta?
«Io credo che quella non fosse nemmeno una promessa sincera, ma l’alibi per porre fine a un periodo di turbolenze diplomatiche che secondo alcuni danneggiavano a tutto tondo le relazioni tra Italia ed Egitto, quindi anche le relazioni economiche. Non c’è stato alcun passo avanti, tant’è che la Procura di Roma ha chiuso le indagini con un rinvio a giudizio di quattro imputati dei quali tuttora non sono messi a disposizione i domicili per l’inoltro degli atti. Intorno alla metà di aprile, un nuovo giudice per l’udienza preliminare stabilirà se un altro tribunale può iniziare un processo. Nel frattempo ci auguriamo che il governo italiano si stia dando da fare, magari in forma non pubblica. La posizione di Amnesty International è quella della famiglia Regeni. Deve esserci un accertamento in sede giudiziaria di quella che chiamiamo la verità storia, cioè che si trattò di un omicidio di Stato».
Alla luce di questa non collaborazione appare ancora più scandaloso il fatto che nel 2020 l’Italia abbia firmato con l’Egitto un maxicontratto per la vendita di armi. Quali sono i rapporti economici e commerciali Italia-Egitto e quanto incidono nelle prese di posizione del nostro Paese nei confronti della dittatura di el-Sisi e quindi dei diritti umani?
«La prima cosa che mi viene in mente sono le questioni legate agli idrocarburi. In tutti questi anni ENI ha proceduto con prospezioni e attività sempre più rafforzate in Egitto. Dunque non ha ricevuto alcun danno di fatto dalle relazioni solo in parte tese. Poi ci sono altre questioni come la stabilità regionale, il contrasto al terrorismo, il ruolo dell’Egitto come soggetto pacificatore nei conflitti tra Israele ed Hamas. Ma anche le questioni legate all’immigrazione che presuppongono che l’Egitto sia un partner importante, da coccolare nel modo più dannoso per i diritti umani. È notizia di questi giorni che l’Unione europea ha espresso la sua candidatura a co-presiedere il Forum globale per il contrasto al terrorismo con l’Egitto, un Paese che ha fatto scempio dello Stato di diritto e dei diritti umani, anche attraverso l’abuso di leggi antiterrorismo che hanno un contenuto generico e che hanno criminalizzato pezzi di società civile importanti, con l’iscrizione nelle liste dei terroristi di difensori dei diritti umani, come Alaa Abd el-Fattah. Per troppo tempo e in troppi modi verso l’Egitto c’è stata una condotta premiale basata su fornitura di armi, consolidamento di relazioni economiche e anche sull’affidamento di ruoli chiave, che hanno tenuto il Paese al riparo da critiche e da scrutini sulle violazioni dei diritti umani».
In tanti anni di attivismo, le è mai capitato di pensare che sia frustrante mobilitarsi con determinazione e coraggio per poi assistere, spesso, all’indifferenza della politica e degli Stati che continuano a perseguire i propri interessi?
«Può essere frustrante ma non c’è giorno in cui all’abbattimento per una brutta notizia non segua la contentezza per una buona notizia. Il 9 febbraio nello Sri Lanka è uscito dal carcere, dopo due anni di detenzione senza processo, un avvocato per i diritti umani accusato falsamente di terrorismo. Il giorno dopo è arrivata la notizia che nel Salvador una donna che era stata condannata a trent’anni di carcere per omicidio aggravato ai sensi delle leggi contro l’aborto è uscita dopo averne scontati dieci. Queste due notizie belle – anche se belle al termine di carcere, dolore e sofferenza – sono quelle che poi fanno da contraltare in quest’altalena continua tra scoramento ed entusiasmo».
Dal Rapporto 2020-2021 sulla situazione dei diritti umani nel mondo, pubblicato da Amnesty, emerge che la pandemia ha messo in luce ed esacerbato paradigmi esistenti fatti di abusi e disuguaglianze. Qual è un’urgenza che il mondo post-pandemico non può più ignorare?
«Il 14 febbraio, Amnesty ha pubblicato una nuova analisi sul comportamento delle Big Pharma in cui denuncia, con dati alla mano, come le aziende farmaceutiche abbiano continuato a vendere vaccini a prezzi elevati agli Stati ad alto reddito condannando la popolazione degli Stati a medio-basso reddito a un’attesa che va ancora avanti. Quello che dobbiamo avere come imperativo nell’immediato è che tutta la popolazione mondiale venga vaccinata entro il 2022. In prospettiva poi bisogna decidere se ricostruire, con i vari piani di ripresa, un mondo diviso, fatto di politiche economiche e sociali squilibrate, o un mondo con sistemi sanitari forti e piani pandemici adeguati dove nessuno sia escluso dalle cure mediche fondamentali».
In questi giorni Amnesty International Italia ha lanciato una petizione online per chiedere al Parlamento di opporsi al rinnovo automatico del Memorandum d’intesa Italia-Libia che dovrebbe avvenire nel 2023. In seguito a quest’accordo bilaterale del 2017, solamente nel 2021 ben 32.425 persone sono state intercettate dai guardiacoste libici e riportate in Libia, andando incontro a detenzione, torture, stupri e morte. Com’è possibile che un Paese civile respinga delle persone in difficoltà sapendo che queste finiranno in veri e propri lager, come li ha definiti anche Papa Francesco?
«All’interno dell’Unione europea c’è un’ossessione della lente dell’immigrazione attraverso la quale vedere i fatti. Questo comporta l’applicazione di misure estreme a tutti i costi. Costi finanziari ingenti ma soprattuto costi umani insopportabili. Il Memorandum Italia-Libia, così come l’accordo UE-Turchia del 2016, ci dice fino a che punto la politica possa arrivare a livelli di cinismo pur di soddisfare questa sua ossessione. È come se, in nome di quest’ossessione dell’immigrazione, la politica diventasse poco più del motto “occhio non vede, cuore non duole”. La politica non solo non vuol vedere, ma non vuole nemmeno far vedere. Da qui derivano le politiche di criminalizzazione del soccorso in mare che vanno di pari passo con gli accordi con gli Stati terzi per esternalizzare».
Perché si guarda con sospetto a chi salva vite umane in mare?
«C’è uno spartiacque preciso che si colloca intorno al 2017, l’anno dell’accordo con la Libia, del codice di condotta di Minniti alle ONG e di quell’espressione infelicissima dei “taxi del mare” dell’attuale Ministro degli Esteri. È come se tutto questo insieme di narrazioni si fosse coalizzato per dare luogo a un disegno criminale che pretende di trasferire parole come solidarietà e accoglienza dal vocabolario del bene, del bello e del giusto al codice penale. Le persone vedono con sospetto chi fa del bene perché associato a un’attività delinquenziale. Ci sono delle precise responsabilità politiche in questo, che hanno nomi e cognomi Questa stagione poi si è acuita con i Decreti sicurezza, che in parte sono stati ridimensionati, ma il rumore di fondo di questa narrazione ostile, velenosa e divisiva rimane».
Se da un lato è importante essere a conoscenza delle violazioni dei diritti umani nel mondo, dall’altro questo rischia di gettarci nello sconforto e di darci l’impressione che nel mondo ci sia solo del marcio. Ci racconti una buona notizia dal mondo.
«Tre giorni fa ho visto un’immagine molto bella: il ricongiungimento familiare tra un difensore dei diritti umani del Burundi e la sua famiglia che è in esilio in Belgio. Lui si chiama Germain Rukuki e nel 2018 era stato condannato a 32 anni di carcere a causa delle sue attività in difesa dei diritti umani. Il Burundi è un Paese che pochi conoscono e su questa storia ci ha lavorato soltanto Amnesty. Abbiamo raccolto centinaia di migliaia di firme che sono state inviate alle autorità del Burundi spingendole a fare un processo d’appello, al termine del quale Germain è stato condannato a 12 mesi. Li aveva già ampiamente trascorsi in carcere e quindi è stato liberato. Agli attivisti di Amnesty andati ad incontrarlo all’aeroporto di Bruxelles, Germain ha detto “E’ merito vostro”. Purtroppo è una storia agrodolce perché quell’abbraccio è avvenuto in esilio, anche se in quella foto non c’era amarezza ma solo gioia».