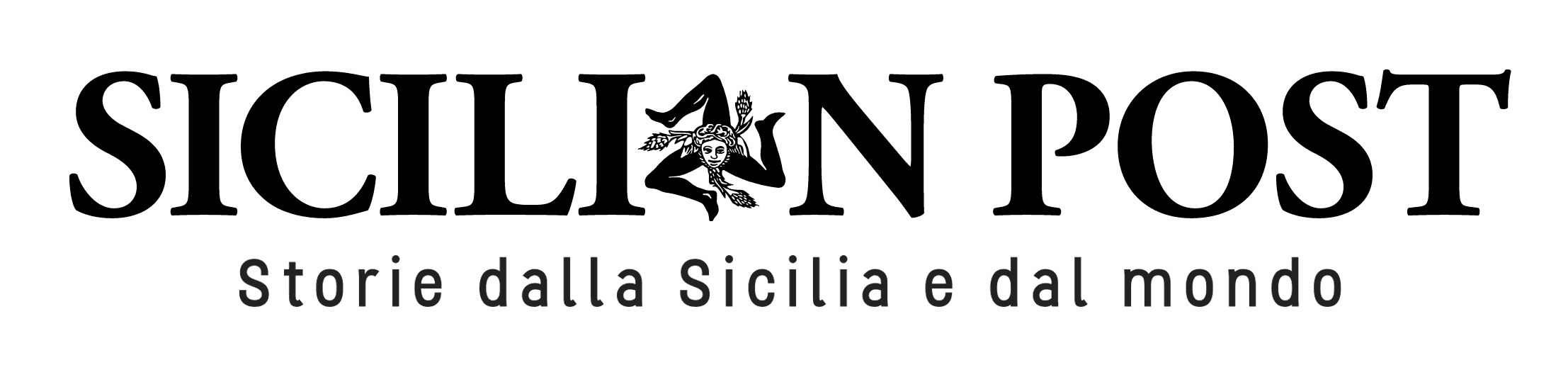Brancati, “Fabiola” e Hollywood: così una sceneggiatura ha cambiato la storia del cinema
È il 1949: le macerie della Seconda guerra mondiale ancora fumano di distruzione. Una grande produzione, tuttavia, si mette in testa di guardare al domani con ottimismo. È il primo grande kolossal italiano, a cui il nostro autore contribuisce con la sua scrittura. Il pubblico ancora non lo sa: ma è da qui che il grande sogno dell’industria a stelle e strisce troverà lo spunto per reinventarsi. E che “Ben Hur”, uno dei più celebri figli direttamente ispirati a quell’idea italiana, diventerà una pietra miliare
Nell’arena di Gerusalemme sta per andare in scena la resa dei conti. I cavalli legati alle quadrighe già scalpitano. I loro zoccoli, battendo per terra, innalzano un velo di polverosa nebbia. Che non impedisce, tuttavia, ai due grandi contendenti, un tempo inseparabili amici, di scrutarsi avidamente negli occhi. Da un lato, il principe giudeo caduto rovinosamente come schiavo e separato da ogni affetto, che con orgoglio ha riacquistato la sua libertà; dall’altro il suo carceriere, comandante di una guarnigione romana, avvelenato dall’odio. Una corsa tra carri deciderà le loro sorti. Il resto, come si suole dire, è storia. Perché l’iconica scena che si conclude con la morte di Messala è uno dei momenti narrativamente più alti del grande kolossal Ben Hur, uscito nelle sale statunitensi nel novembre del 1959 e considerato unanimemente dalla critica come una delle più grandi pellicole di tutti i tempi. Non solo per la straordinaria performance attoriale di Charlton Heston, o per la sapiente regia di William Wyler – che aveva già conquistato il mondo insieme con Audrey Hepburn e Gregory Peck grazie a Vacanze romane (1953) – ma anche, e soprattutto, per l’intensità di una storia che scorre sullo sfondo delle vicende di Gesù Cristo e che riflette sull’insensatezza della vendetta e sulla necessità del perdono, realtà dinanzi alla quale non esiste gerarchia tra dominatore e straniero. C’è poi, tra le pieghe del film, una notevole valenza simbolica per l’intera storia cinematografica: Ben Hur fu, in qualche modo, una dichiarazione d’intenti. La maturazione di un’industria, quella hollywoodiana, che di slancio si affacciava ai fulgidi anni ’60. La prima grande, gigantesca produzione della fabbrica dei sogni americana. Pochi sanno, tuttavia, che il fondamento di quel successo va ricercato in un’altra pellicola, tutta italiana. Alla quale contribuì anche un grande siciliano, Vitaliano Brancati. Parliamo di Fabiola, film del 1949 che vide il nostro conterraneo impegnato nella stesura della sceneggiatura. Una produzione travagliata, con tempi estremamente dilatati, prodotta tra le macerie ancora fumanti della Seconda guerra mondiale. Ma destinato, forse al di là della consapevolezza degli autori e del regista Alessandro Blasetti, a diventare un archetipo.
«Quando ero bambino, mia madre diceva che c’è sempre qualcuno davanti alla nostra porta, io correvo ad aprire, non vedevo nessuno, lei sorrideva e mi diceva: “Non hai guardato bene, Rhual”. Ora credo… credo di capire quel che voleva dire mia madre. Che non ci siamo noi soli al mondo, Fabiola, capisci? Niente al mondo è stato fatto per noi soli»
“Fabiola”, 1949
Perché è proprio con Fabiola, con la sua ambizione e le sue variegate maestranze, che il cinema conobbe la sua rinascita. La guerra non aveva fiaccato la fantasia, il desiderio di esplorare orizzonti ignoti, di restare aggrappati al conforto del grande schermo. E qui si era innestata la grande pellicola di ambito romano che aveva come protagonisti Michèle Morgan e Henri Vidal. Una pellicola – vagamente ispirata ad un omonimo romanzo scritto un secolo prima da Nicholas Wiseman – capace di fare scuola con il suo intreccio e il suo coraggio. Nella vicenda del gallo Rhual, del resto, si formano e si cristallizzano i grandi stilemi della narrazione storica: partito per Roma, il giovane viene impiegato come gladiatore al servizio del senatore Fabio Severo. È una vita di sangue, di stenti, di precaria risolutezza. Una vita che, nonostante tutto, non deturpa il suo animo nobile. Quando il suo protettore, infatti, viene assassinato per ordine imperiale, Rhual si schiera a favore dei cristiani ingiustamente additati come responsabili. Persino l’amata Fabiola, figlia di Severo, dubita della sua buonafede, almeno finché non assiste ad un brutale martirio di un cristiano. Offre all’uomo una via d’uscita, ma egli si rifiuta. È il momento di svolta: Rhual comprende che sì, combattere si deve, ma per un valore più alto, inestimabile, intoccabile. Spedito nuovamente nell’arena, si rifiuta di generare altro dolore, di alimentare altra violenza. La scintilla del suo coraggio divampa: i suoi avversari, uomini fino ad allora destinati a far morire e a vedersi morire, lasciano cadere le armi. Il loro destino sembra segnato: ma quando tutto sembra perduto, ecco avanzare i soldati di Costantino. Rhual viene prelevato e salvato. La speranza, e l’amore ritrovato di Fabiola, hanno trionfato.
Lo straniero che insegna la pietà alla boria imperialista di Roma. Gli affetti che sembrano dissolversi, tradire, sgretolarsi sotto i colpi dei nemici, per poi riaffiorare ed avvolgere, lenire, trarre in salvo, rivelarsi come l’unico appiglio di speranza nel tumultuoso vorticare dell’esistenza. L’affermazione di un mondo diverso, che faticosamente tenta di lasciarsi alle spalle la zavorra bellica, nazionalista, individualista. Fabiola è, a tutti gli affetti, l’antecedente di Ben Hur. Il capostipite di un ritrovato slancio, di cui un altro illustre figlio sarà Quo vadis (1951). E sembra quasi di vederlo, Ben Hur, nello splendido discorso che Rhual rivolge alla sua amata: «Quando ero bambino, mia madre diceva che c’è sempre qualcuno davanti alla nostra porta, io correvo ad aprire, non vedevo nessuno, lei sorrideva e mi diceva: “Non hai guardato bene, Rhual”. Ora credo… credo di capire quel che voleva dire mia madre. Che non ci siamo noi soli al mondo, Fabiola, capisci? Niente al mondo è stato fatto per noi soli».
La scintillante storia di Hollywood avrebbe da lì spiccato il volo. Avrebbe fatto da trampolino di lancio per Stanley Kubrick (Spartacus, 1960); avrebbe incoraggiato la realizzazione fuori scala di Cleopatra (1963) con Liz Taylor e Richard Burton. E sarebbe arrivato fino al Gladiatore di Ridley Scott e Russell Crowe. Ma è tra le strade di Cinecittà che tutto conobbe il suo inizio. E pure, in un certo senso, tra quelle di Pachino.