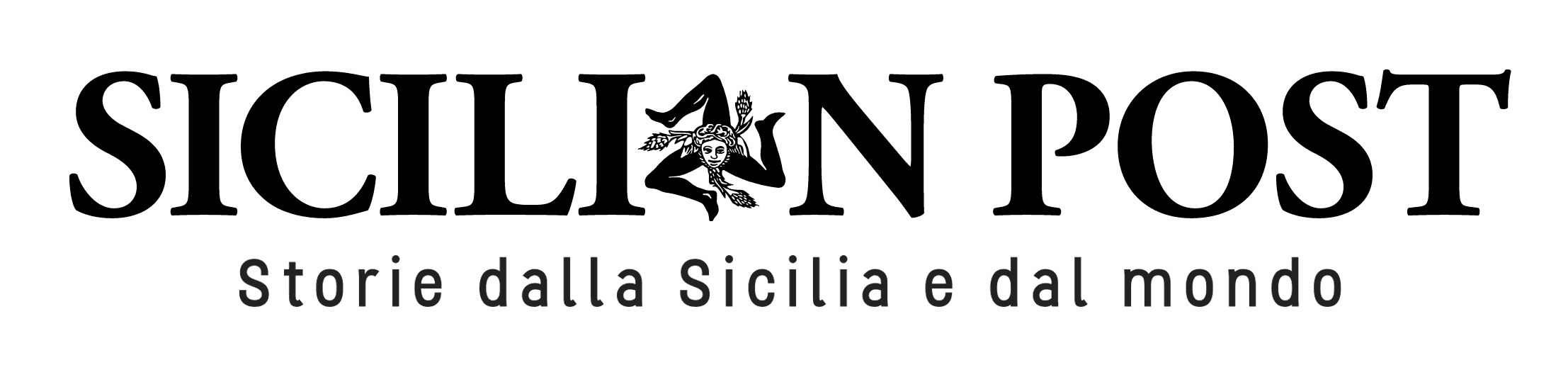Coleridge, l’Etna e un amore profetico: la Sicilia con gli occhi del padre del Romanticismo
A condurlo sull’isola nel 1804 fu il bisogno di un clima salutare per curare la febbre reumatica. Ma il grand poeta inglese aveva già varcato i confini nostrani qualche anno prima, con un commovente testo che racconta il disperato innamoramento di un monaco per una novizia alle pendici dell’Etna. Il destino aveva già predisposto tutto: e quando finì per soggiornare nella nostra terra, si ritrovò proprio all’ombra del vulcano. Ospite di un famoso monastero…
«La poesia è il flusso spontaneo di sentimenti forti che trae origine dall’emozione, raccolta nella tranquillità». Due righe per suggellare l’eternità. Due righe per inaugurare il trionfo del sentimento dell’infinito. Due righe per ristabilire la natura come teatro privilegiato delle passioni umane. Quando scrisse la prefazione alla seconda edizione delle Ballate liriche, nel 1801, William Wordsworth non immaginava, probabilmente, che le sue considerazioni avrebbero letteralmente squarciato il velo del tempo. Che sarebbero diventate il motto di svariate, innumerabili generazioni di poeti. E che sarebbero state riconosciute come l’intuizione, la materializzazione concettuale del nascente Romanticismo. E un po’ come un impressionista della penna, l’autore inglese amava vagheggiare, planare con l’immaginazione, tratteggiare fugacemente, librarsi all’ombra di paesaggi animati dal vento. Chiamava a raccolta l’anima di quei luoghi e ne restituiva, sulla pagina, l’eco lontana, il sottile, soffuso riverbero. Ma non era solo, Wordsworth, nell’impresa che ha cambiato il corso della storia letteraria. Accanto a lui – spesso fisicamente impegnati a quattro mani nella stesura delle Ballads – un altro prode ingegno: quello di Samuel Taylor Coleridge, conosciuto principalmente per la straordinaria composizione de La ballata del vecchio marinaio. Il suo animo tormentato, ingrigito a fasi alterne da una drammatica dipendenza agli oppiacei, trovava conforto e sublimazione esclusivamente nella poesia. Nell’attimo sospeso, nel canto in libertà, nel volteggio aggraziato di un verso. Anche a lui, all’altezza cronologica in cui quella sorta di manifesto poetico stava per vedere la luce, sfuggiva qualcosa: che il fato gli avrebbe concesso di vivere sulla pelle e sul cuore la profezia sulle emozioni elaborata dal collega. Quando i postumi di una febbre reumatica lo condussero ad abbracciare il salubre clima siciliano, tra i vigneti e i boschi dell’Etna. Quando quello squarcio inatteso di vita si tramutò in una commovente lirica.
L’approdo di Coleridge sull’isola – stando alle datazioni delle lettere spedite alla moglie Sarah e agli appunti raccolti nei suoi Notebookes – avvenne sul finire dell’estate del 1804. Come spesso accadeva per i forestieri impegnati nel Grand Tour, il poeta fu impegnato più volte nell’ascensione al vulcano e trovò riparo presso il Monastero di S.Nicolò lo Bosco. Fu proprio tale luogo – come ha ben ricostruito Valentina Mirabella – a determinare l’eccezionalità del suo soggiorno. Con l’occhio indagatore del poeta, con accenti che curiosamente e vagamente anticipano quelli della purezza malinconica della Capinera verghiana – Coleridge si lasciò ammaliare dal contrasto cromatico tra la cenere e la vegetazione, tra l’impetuosa maestà dei pendii vulcanici e il fluire di una silenziosa pace: «Oh, che posto amabile / betulle o pioppi, sembrava un tronco di betulle con foglie di pioppo… E alberi di pino, prima della fattoria grande e bianca, e dietro e intorno vigneti e colline boscose e colli coperti di viti, le vigne crescono sulle lave ridotte in polvere, una meraviglia, assomiglia alle polveri metalliche che poi si fondono in una porta forgiata / nessuna traccia di forma vegetale può essere vista / io salgo sulla collina, il suolo ardente sotto i miei piedi, e con gioia entro nel bosco lì in alto, formato da betulle e querce». In quell’oasi di magia il poeta inglese aveva ritrovato sé stesso. In ogni possibile significato. Perché la Sicilia, per Coleridge, fu la meta, in realtà, di una doppia profezia. La dimora di un sogno manifestatosi anni prima – precisamente nel 1800 – con la carica di un fulmine. Il cui titolo recava già in sé le tracce di quel futuro incontro: Il monaco folle.
È un monologo disperato, un lamento d’amore a tratti straziante, l’abisso di un uomo vincolato al suo eterno voto, che vacilla, si batte il petto, maledice il suo sentimento per la giovane novizia Rosa, che tuttavia rivolge i propri pensieri altrove. I suoi sospiri rimbombano tra le grotte dell’Etna e scendono fino a valle come lava incandescente. È un’ode misteriosa alla bellezza, al totalizzante sentirsi prigioniero dell’altro, ad uno scenario grandioso e intimamente coinvolgente, letterario. Uno scenario nel quale lo scrittore si sarebbe ritrovato egli stesso come personaggio:
«E dall’interno della caverna giunse
Una voce; – era ancora lui!
E così, con tono funereo, rinnovò il suo cupo lamento:
“La scorsa notte camminavo su un verde pendio,
Il prato calmo mi diede una visione,
Sotto i miei occhi il tappeto erboso –
La volta del sepolcro di Rosa!
“Il mio cuore ha bisogno di lottare contro sogni come questo,
Quando mi risvegliai, trovai sotto i miei occhi
Una zolla di terra muschiosa,
Quella su cui spesso sedemmo quando Rosa era viva.
Perché le pietre e gli argini del fiume,
Perché le colline generatrici di piccoli fiori devono
Somigliare così tristemente ai colori del sangue di una fanciulla morta?
“Toccai la mia ferita,- con questa mia mano!
Oh, per te, divina fanciulla,
Io amai fino allo spasimo!
Il giovane che chiamasti tuo
Mai ti amerà quanto me!
[…]
Oh, lascia che smetta per sempre di diffondere
Questi toni di spettri cremisi!
Oh, lasciami in pace, e per sempre!
Qui la voce si spense. In profondo sgomento,
Giù per il bosco proseguii il mio cammino».
Sembra quasi di vederlo, Coleridge, proprio come il viandante che si imbatte nelle lacrime del monaco andare avanti per la sua strada, lasciarsi alle spalle la meraviglia di cui era stato testimone, la devozione di quegli uomini e la loro accoglienza. Sembra di vederlo, pensieroso su quelle circostanze, su quel magico sovrapporsi tra vita e poesia, sull’esperienza di quel viaggio che gli si era fatto incontro in uno dei momenti più complicati della sua esistenza. E sembra quasi di sentirlo, in preda allo stesso fremito, formulare un difficile congedo. Mentre la sua amata Sicilia si prepara a rivolgere a qualcun altro le sue premurose attenzioni. Lasciando all’inglese il ricordo di una tranquillità che presto avrebbe nuovamente smarrito.
(Immagine in copertina: Washington Allston, Potrait of Samuel Taylor Coleridge)