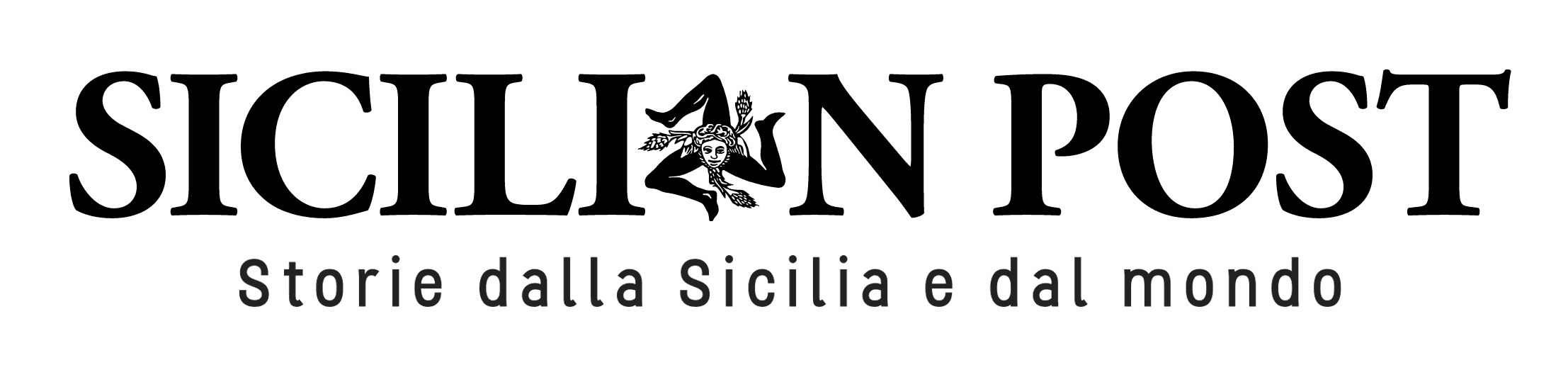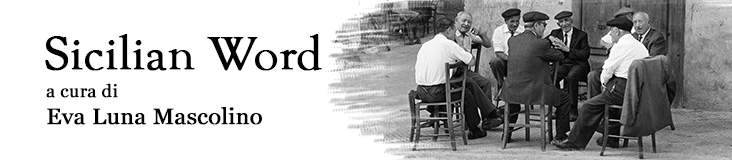Frutta estiva in Sicilia: alla scoperta dell’etimologia dei prodotti più comuni
Come forse avrete notato, nella Trinacria chi la vende per strada è raro che descriva la propria merce in lingua italiana, data l’abitudine istintiva a esprimersi in dialetto e a dare a ogni frutto un nome non sempre riconoscibile. Dalle ciliegie all’uva, vediamo insieme i più diffusi, alcuni dei quali sembrano avere una provenienza piuttosto esotica
Che siate del posto o meno, se avete trascorso anche solo qualche giorno in Sicilia durante la stagione estiva vi sarete senz’altro accorti del fatto che camionette e venditori ambulanti sono disseminati un po’ ovunque nei centri urbani e nelle località di vacanza. Tra chi vende il cocco e chi i surgelati, oltre all’immancabile arrotino, una figura-chiave della realtà quotidiana isolana è quella del fruttivendolo, che porta con sé ogni sorta di prelibatezza per gli amanti di una cucina fresca, sana e ricca di sali minerali. Come forse avrete notato, tuttavia, è raro sentirli vendere la propria merce in lingua italiana, dato che le loro origini spesso umili li portano d’istinto a esprimersi con fierezza in dialetto, dando a ogni frutto un nome non sempre riconoscibile.
‘A racìna, per esempio, ha origine francese e corrisponde all’uva, proprio come ‘a ciràsa, che proviene dallo stesso idioma e che è invece l’equivalente della ciliegia. Più semplici, forse, i casi di ananàssu, mulùni e ficu r’Inia, cioè ananas, melone (o cocomero) e fico d’India, che condividono l’etimologia con l’italiano. Il primo, infatti, è un frutto tropicale il cui nome originario era nan in guaranì, poi giunto nel Vecchio Continente attraverso l’adattamento portoghese anans nel XVI secolo. Il secondo viene dal latino tardo melonem, abbreviatura del termine greco mēlopépōn, e il terzo arriva invece direttamente dal Messico, terra che come il resto del continente americano Cristoforo Colombo aveva inizialmente scambiato per l’India, diffondendo così il suo nome con una falsa provenienza geografica.
Una forma meno intelligibile hanno, invece, pesche e albicocche, che in siciliano si trasformano rispettivamente in pèrsica e varcòcu, entrambe con innumerevoli varianti in base al singolo Comune. L’una è da fare risalire all’aggettivo greco Persikós, che indicava il popolo persiano e dalla cui area si suppone quindi che provenisse questo frutto. L’altra, invece, ha la stessa radice del sostantivo arabo barquq, derivato però dal greco praikòkion, a sua volta adattato dal latino praecoquus, ovvero precoce, riferito alla frutta primaticcia. La prossima volta che vi capiterà di imbattervi in un venditore ambulante, quantomeno saprete destreggiarvi meglio fra la provenienza curiosa (e non sempre prevedibile) di parole dal suono e dalla storia affascinante.