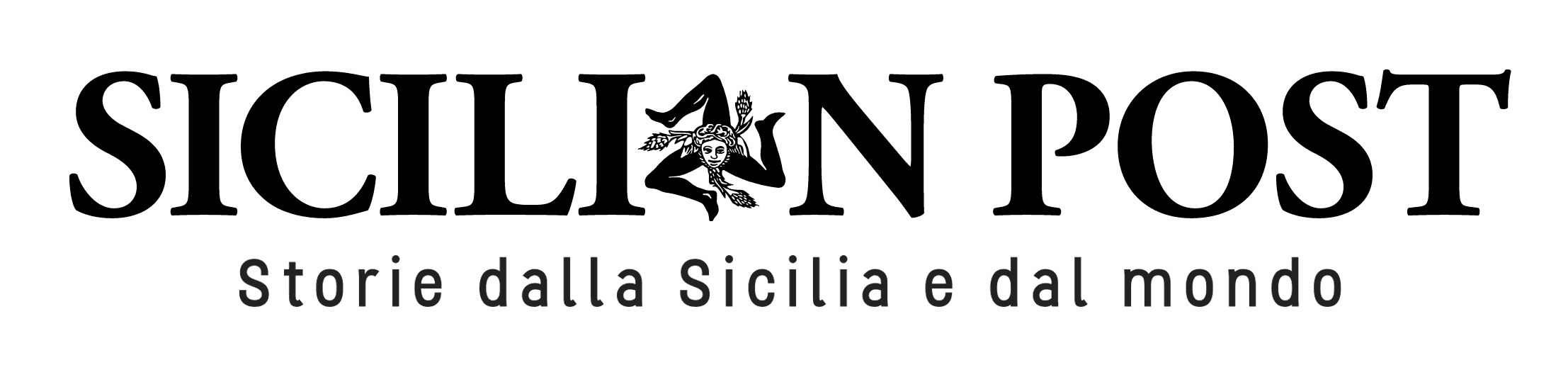I segreti di una spia che danzava come una dea: Sciascia e i giorni di Mata Hari a Palermo
A distanza di più mezzo secolo dalla morte della conturbante ballerina olandese che aveva conquistato il cuore di tutta Europa, anche lo scrittore siciliano aveva ceduto al fascino di quella figura intrigante, assoldata dai tedeschi come spia durante la Prima guerra mondiale e poi arrestata e fucilata perché scoperta a fare il doppio gioco con i francesi. La sua permanenza in Sicilia fu breve, ma avvolta da tante nubi: perché, nonostante la fama, si esibì in un teatro piuttosto umile? Cosa la portò nel capoluogo? Era forse già all’opera come 007?
Oltre il confine delle pagine, oltre il poliestere della pellicola o il drappeggio di un sipario, c’è un tòpos letterario che ha avuto la forza di affermarsi come reale, come suadente e carnale materializzazione di una suggestione di lunga data. È il tòpos della danza: che fa rima con grazia, certo. Ma anche con pericolo, con inganno, con istinto incontrollabile, con follia. Sa essere frenetica, incalzante, martellante come un’eco ipnotica che si incastra nella mente. Altre volte è lenta, sussurrante, avvolgente come le spire di un anaconda. Attrae e spaurisce, invita e disorienta. Inneggia all’arte, ma anche a qualcosa di insondabile, a segreti inconfessabili che si librano sul filo della vita e della morte. È l’incedere dell’ambiguità, la profezia di un disastro, l’estrema, incontrovertibile affermazione della libertà o del sacrificio di sé stessi. La danza è, essenzialmente, il linguaggio di un mondo precario, ribaltabile in un istante, aggrappato alla sorte e alle congiunture astrali, alla malizia e all’ingenuità. Il mondo delle spie, archetipi di un silenzio fatale, vagabondi della storia e della leggenda che sfilano nelle più galoppanti fantasie dell’immaginario collettivo. E lo fanno sempre, rigorosamente, danzando. Come non pensare a Licenza d’uccidere (1962), primo capitolo della saga cinematografica di James Bond, nel quale Sean Connery viene fatto vacillare da una sfrenata ballerina di danza del ventre? O, sempre per rimanere in tema 007, a Thunderball (1965) e Mai dire mai (1983), nei quali è lo stesso agente segreto britannico a sfruttare il suo charme da danzerino – e tanghero – provetto per raggiungere i suoi scopi? Né si potrebbe ignorare in questa singolare equazione la vita di Joséphine Baker, sublime danzatrice afroamericana poi naturalizzata francese e protagonista di ardite imprese di controspionaggio durante la Seconda guerra mondiale. A quel mondo apparteneva anche un’altra celebre donna. Una donna che, seppur brevemente, incrociò la Sicilia. Il suo nome – o, per meglio dire, il nome che le sue gesta le avevano acquistato – era Mata Hari. A lei Sciascia, a più di mezzo secolo dalla sua tragica morte, avrebbe dedicato alcune delle sue più intriganti pagine investigative. Pagine cariche di curiosità, ma anche, vagamente, di intellettuale ammirazione. Pagine che tuttavia, come si conviene ad una spia, non diradano ogni nube.
L’interesse sciasciano, tradottosi poi nella stesura di uno dei sette saggi che compongono le Cronachette (1985), nasceva da un fatto decisamente insolito: a cavallo tra agosto e settembre 1913, la conturbante olandese si trovava a Palermo. A quale scopo o chi l’avesse voluta lì erano gli interrogativi che lo scrittore siciliano desiderava affrontare di petto. Una strana traiettoria, del resto, ne aveva sicuramente guidato il cammino. Come aveva fatto sin dalla sua giovinezza, quando appena ventenne, nel 1897, aveva sposato il capitano Mac Leod e si era trasferita in Indonesia, all’epoca possedimento olandese. Nozze infelici, fatte di solitudine e di maltrattamenti, che tuttavia l’avevano introdotta tra le esotiche strade di Giava, grazie alle quali, tra folklore e spiritualità, aveva appreso in un tempio le movenze delle danze locali. Trasferitisi a Parigi tra il 1902 e il 1903, i due coniugi erano andati incontro ad un’inevitabile separazione. Ma proprio in quel frangente così buio ed infelice era iniziata la nuova vita di Margaretha (suo vero nome). Nel giro di qualche mese, i suoi passi così anticonvenzionali e le sue doti da cavallerizza avevano calamitato l’attenzione di tutta la capitale francese: imprenditori, impresari, ricchi nullafacenti facevano a gara per assicurarsi una sua esibizione e il favore del suo cuore. Racconti acrobatici e fantasmatici ne accompagnavano ogni spostamento: si diceva – e lei stessa non si preoccupava di smentire – che avesse imparato l’arte della danza direttamente dal dio Shiva, che uomini disperati si erano tolti la vita perché non ricambiati nel loro sentimento, che nessun ufficiale era mai sfuggito ai suoi giochi di seduzione. Era nato il mito di Mata Hari (in malese: “occhio dell’alba”), era nato un fenomeno di portata europea. Le più importanti capitali le avevano aperto i teatri più iconici, dall’Olympia alla Scala: critici, biografi ed artisti (tra i quali Puccini) ne esaltavano la leggiadria, la sfrontatezza mai volgare. Il mondo era stato travolto al ritmo gitano, orientale del suo incedere. Ma qualcosa, alle porte della Grande Guerra, stava per cambiare. La sua eccezionalità stava per tramutarsi in una condanna. Il suo carisma e la sua sicurezza stavano per farla sprofondare in un gioco ben più grande di lei. Un gioco che, a leggere Sciascia, aveva iniziato a muovere le sue fila già a Palermo.
Le esibizioni siciliane di Mata Hari, infatti, avevano avuto luogo presso il Trianon, non esattamente il più prestigioso dei teatri del capoluogo. Benché, dunque, fosse stati ipotizzato che dietro l’approdo nell’isola della diva ci fossero i Florio, Sciascia propendeva per un’altra ipotesi, ovvero che, al massimo, richiedere la sua presenza fosse stato un qualche barone squattrinato e indebitato, tronfio a tal punto da vantarsi della sua conquista pur senza avere le coperture economiche necessarie. A quel punto, l’artista avrebbe accettato pur in seguito ad un tentennamento iniziale. La ragione? Forse il timore che il suo rifiuto ad esibirsi in quella location d serie b le sarebbe valso il sequestro del bagaglio. Perché, allora, tanto timore? Forse perché, proprio alla vigilia dello scoppio della Prima guerra mondiale, Mata Hari era già stata assoldata come spia dai tedeschi, divenendo l’agente H21, in un eterno gioco di rifrazioni e di contraddizioni che l’avrebbe accompagnata fino alla fine: «Ma la convinzione che Mata Hari non fosse in grado di sostenere il ruolo di spia a Waagenaar (uno dei suoi più celebri biografi,ndr) viene forse e dall’averne scrutato la vita privata, piuttosto semplice e casalinga e da una supervalutazione degli ingranaggi spionistici e delle menti che le guidano: mentre io credo si muovano sempre – allora come ora – in un giuoco delle parti, e ogni parte in giuoco doppio, di informazioni false ritenute vere e di informazioni vere ritenute false, e insomma in una specie di atroce nonsense». La spia perfetta, insomma. Che non destava sospetto né al picco della sua esposizione mediatica né nel privato di una quotidianità apparentemente inconsistente. Che quella capatina palermitana celasse, in realtà, una missione delicata che valeva la pena camuffare dietro l’insoddisfazione bizzosa di una star?
Forse. Probabile. Anche perché, da Palermo, aveva avuto origine il turbine di eventi decisivo per la sua vita. La pratica del doppio gioco si era quasi impossessata di lei. Anche i francesi l’avevano voluta come spia. Spia delle operazioni tedesche. Si era fatta largo a suon di tresche amorose e compensi sempre più lauti per le preziose informazioni di cui era in possesso. Il suo voltafaccia alternato durò sino al 1917, quando venne arrestata a Parigi. Il processo non le lasciò scampo, benché diversi degli ufficiali che la amarono tentarono persino di difenderla. Un ultimo colpo di scena nel grande teatro della vita che aveva calcato come poche altre. Un ultimo, elettrico passo di danza. Il 15 ottobre di quell’anno venne fucilata. E con lei ancora tanti, troppi segreti. Compresi quelli che rimangono sepolti a Palermo.
(In copertina: Mata Hari nel 1915 fotografata da Jacob Merkelbach)