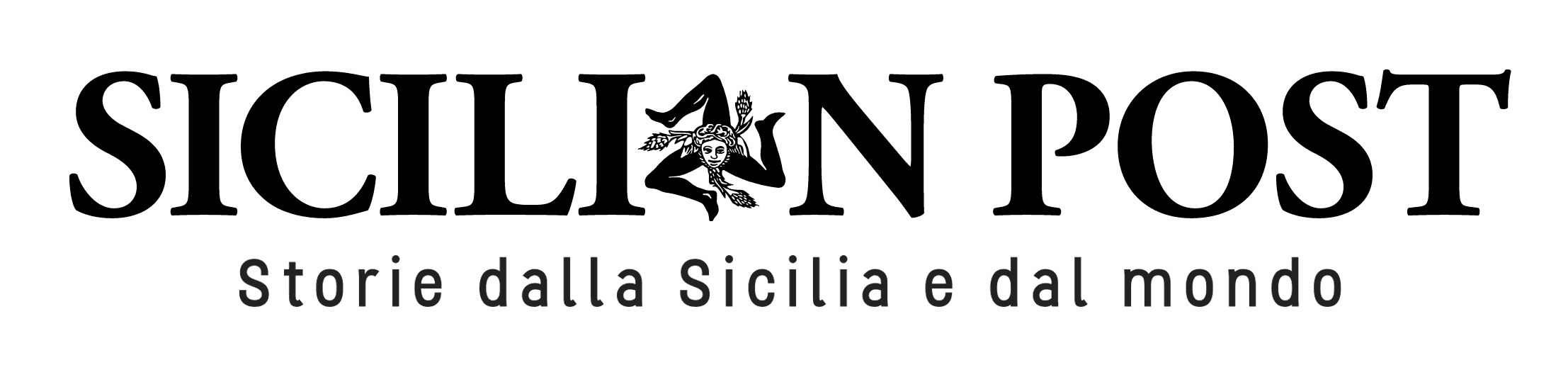Il coraggio di amare e di soffrire: i sonetti dimenticati di Graziosa Casella
Nata a Catania agli albori del’900, fu una poetessa assolutamente fuori dagli schemi: unica donna a ritagliarsi un ruolo in una città e in un’epoca a forte trazione maschile, diede spazio al suo sentimento allora considerato scandaloso per un uomo ben più giovane di lei. Ci restano, della sua produzione, solo alcune delle poesie scritte in siciliano. Ma tanto basta per riportare alla luce quella dolce, sanguigna, onesta poetica dell’assenza
A proposito di una delle connotazioni più dolorosamente comuni del sentirsi innamorati, scrive così Roland Barthes nei Frammenti di un discorso amoroso: «All’assente, io faccio continuamente il discorso della sua assenza; situazione che è tutto sommato strana; l’altro è assente come referente e presente come allocutore. Da tale singolare distorsione, nasce una sorta di presente insostenibile; mi trovo incastrato tra due tempi: il tempo della referenza e il tempo dell’allocuzione: tu te ne sei andato (della qual cosa soffro), tu sei qui (giacché mi rivolgo a te). Io so allora che cos’è il presente, questo tempo difficile: un pezzo di angoscia pura». Non esiste, per chi si strugge, un piano temporale al di fuori del presente. Il passato è accartocciato su sé stesso, un nastro di musicassetta aggrappato al suo rocchetto. E il futuro si appiattisce, sbiadisce. Resta solo un eterno adesso. Una voragine di promesse, un ponte sospeso e traballante sul burrone dei rimpianti. In quel vuoto, in quella voragine sensoriale, come palliativo, parziale risarcimento dell’oggetto perduto, solo le parole possono insinuarsi, prendere forma. È la condanna – e l’eccezionalità – del poeta. La sua confessione e la sua maledizione. Scrive ancora Barthes: «L’assenza si protrae e bisogna che io la sopporti. Io devo perciò manipolarla: trasformare la distorsione del tempo in un movimento di va e vieni, produrre del ritmo, aprire la scena del linguaggio». Sopportare. Convivere. Senza riserve, senza speranze. È la storia di una poetessa fuori dagli schemi. Una catanese indomita, a lungo osteggiata perché donna libera in un mondo di uomini. Un’ardente amante, una scrittrice carnale, anticonformista. È la storia di Graziosa Casella, e del prestigio che nella prima metà del ‘900 ne accompagnò i passi, tra la natia Catania e Acireale. Prese posto nei circoli intellettuali più in voga del tempo, pubblicò su riviste e giornali, e di uno fu pure redattrice (per Lei è il lariu, testata irriverente che il fascismo si era naturalmente affrettato a chiudere). Quel poco che ci resta di lei, tuttavia, è indissolubilmente legato ai versi d’amore. Ad un sogno amaro che mai conobbe il suo lieto fine.
La sua vita fu infatti segnata dal tenero e disperato amore per Vanni: sentimento sul quale mai mancarono maldicenze e discrediti. Una importante differenza di età li separava: lui giovane ed aitante, lei più in là con gli anni e tormentata da un estenuante tira e molla, nonché dal peso di un sentimento, per l’epoca, socialmente inaccettabile. Nei sonetti che sono giunti fino a noi – poco meno di una decina e raccolti eloquentemente in Autunnu e primavera – come il profondere e il ritirarsi di una impetuosa marea si agitano le fasi di un rapporto fulmineo, sanguigno, ingenuo. La fase della speranza, dell’impeto che sopravanza il tentennamento: «È veru sì, s’avissi diciott’anni, / o puru vintott’anni, comu a tia, / non li patissi tanti disinganni, / né mi vinissi sta malincunìa. Ah, si ssa vucca to non è sincera, / làssami stari pri la me svintura… / cu autunnu non s’accoppia a primavera». Ma anche quella dello straziante addio. «A la casuzza so trova ristoru / ognunu!… / Sulu iù, Vanni, ppi tia / paci non trovu no, / fina ca moru». Del materializzarsi di una insopportabile solitudine. Dell’abbandono che non reca con sé alcuna spiegazione, se non quella della sua stessa ineluttabilità. «E scuru fittu – scrive in Malincunia – vidu a tutti banni / e a tutti banni sentu spini funni / e cercu e chiamu sempri: Vanni! Vanni! / Na stu silenziu chinu d’amarizza / stu celu grigiu sulu m’arrispunni / dànnumi lu so chiantu a sbrizza a sbrizza».
Quando si spense, nel 1959, la Catania a cui aveva dedicato la vita non le rese un omaggio all’altezza. Manoscritti e liriche andarono perdute e i suoi meriti poetici vennero presto, troppo presto, eclissati. Forse perché quella donna, che ebbe il coraggio di amare e di raccontarsi, di dare dignità ad un desiderio malvisto e persino al dolore, rimane, ancora oggi, difficilmente classificabile. Poetessa dell’amore, certo. Ma anche della verità contro l’ipocrisia e le accuse. Poetessa dell’assenza, ma anche della riaffermazione di sé.
(Immagine in copertina: Tranquillo Cremona, “Visita alla tomba di Giulietta”, 1862)