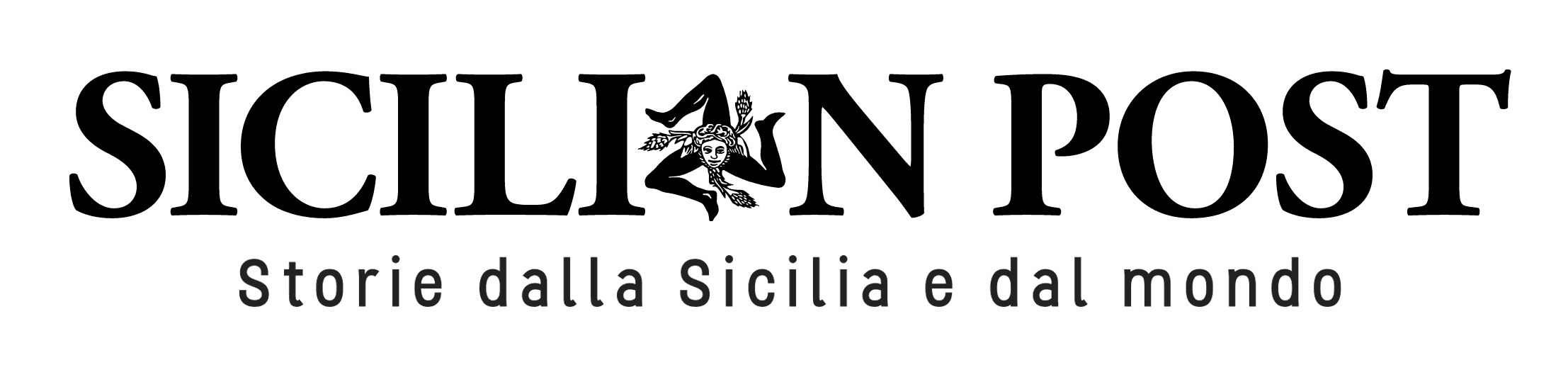L’amore è più forte della guerra: Vitarelli, “Placida” e il coraggio di sperare
Quando balzò agli onori delle cronache nel 1983 con il suo primo romanzo, lo scrittore messinese era già avanti con gli anni. Ma questo non gli impedì di tratteggiare la storia di un adolescente che, nell’estate del ’43, fuggito dalla città dello Stretto assediata dai bombardamenti, scopre che ci può essere luce anche all’inferno. Fiori tra gli ordigni. Amore in mezzo all’odio. Quel romanzo è oggi caduto in un semi-anonimato. Ma il suo messaggio, in questo nuovo tempo di conflitti, è ancora di incandescente necessità
Tra tutti gli stati d’animo che contraddistinguono la vita umana, ce n’è uno che, a prescindere dalle circostanze, è in grado di mantenere intatta la sua forza. O, almeno, così la pensava il grande romanziere e poeta argentino Julio Cortázar, che a tal proposito scrisse: «Probabilmente fra tutti i nostri sentimenti l’unico che non è veramente nostro è la speranza. La speranza è propria della vita, è la vita medesima che si difende». Rimane intatta, la speranza. Non si dissolve, nemmeno quando ci si sforza di negarla, di darla per vinta. Neanche quando ciò che le sta intorno si deforma, si imputridisce di rassegnazione, cambia sinistramente aspetto. Si autoconserva, si autoalimenta, cavalca l’inconscio nascondendosi alla vista della ragione. Trova il suo cammino dove le strade sono state fatte saltare. Combatte l’odio anche quando la sua sorte sembra scritta in partenza, pennella di colore il grigiore che la morte si è lasciata dietro. Si innalza come uno stendardo nel bel mezzo delle guerre e delle miserie, esplode con la stessa veemenza di un ordigno, sorregge coscienze che altrimenti precipiterebbero al suolo. È un pensiero, una meravigliosa utopia. Ma è anche lo schiamazzo dei bambini che giocano sulla terra arsa sino alle radici, l’alba che si ripresenta puntuale al suo appuntamento, il fuoco che divampa, lambisce, ma poi risparmia, passa oltre. È il volto di un adolescente che sa ancora provare meraviglia, che nella sofferenza scopre che può esserci spazio per la dolcezza, che non lascia soccombere la sua purezza. Di un adolescente come quello che accompagnò l’esordio letterario del messinese Eugenio Vitarelli, nato nel 1927, narratore pressoché dimenticato e balzato agli onori delle cronache piuttosto tardivamente, nel 1983, con il romanzo Placida. Un fenomeno letterario che si meritò anche le considerazioni di Leonardo Sciascia, prima di sprofondare in un semi-anonimato che solo di recente, per merito della casa editrice Mesogea, è stato interrotto. Appena in tempo per ribadire la sua scottante attualità. Per ribadire che anche nell’inferno più tenebroso possono incunearsi delle crepe di luce.
A quelle scopre di potersi affidare il giovane Simone, che nell’afosa e cruciale estate del ’43 è costretto ad abbandonare una Messina devastata dai bombardamenti e a trasferirsi con la famiglia nelle campagne di Spadafora. Ma anche qui l’orrore non sembra voler rinunciare a seguirlo: con cadenza terribilmente scientifica, anche il paese degli sfollati è vittima di continue incursioni italo-tedesche. Tutto appare, dinanzi a quel cuore ancora sgomento di giovinezza, sclerotico, fuori posto, insensato. I matti della comunità camminano fianco a fianco con le prostitute, i relitti degli aerei abbattuti in volo giacciono nei campi un tempo floridi, accanto ai corpi abbandonati di chi non ce l’ha fatta. Di chi, senza colpa, da un giorno all’altro si è ritrovato bersaglio del male. E, quasi vittima di un contrappasso dantesco, tra le ali paurose di questa rovina Simone è costretto, dall’apprensione dei genitori, ad un faticoso e quotidiano andirivieni con la casa di famiglia, per verificare che sia ancora in piedi. Ogni giorno il paesaggio gli si consuma sotto la suola delle scarpe. «Erano venti giorni, a cavallo di quel luglio-agosto di strage, che venivo ogni mattina dalla montagna, dove con mio padre e mia madre mi ero rifugiato quando la distruzione aveva raggiunto anche i paesi lungo la costa, ma appena giungevo all’affondare di montagne e colline nella pianura sentivo ancora i peli delle braccia rizzarmisi al pensiero di dover entrare in quell’aria e quelle viste. Un tempo era una campagna a uliveti e grano, e a frutteti di albicocchi, peri e fichi, e a giardini d’agrumi. adesso non c’erano contadini né viandanti che cogliessero frutti dalle piante, sia per la fuga dalla morte, che aveva svuotato i casolari della piana, sia per la nausea di servirsi di quelle frutta impestate dai morti lì dintorno. (i frutteti dove mi fermavo a ristorarmi erano lontani, su altre pendici dei peloritani, intoccate, dove l’aria era fresca e la fragranza dei frutti intatta.) a vederla dall’alto, la pianura appariva come un’immensa pelle ammalata. L’antica e varia bellezza s’era rattrappita in uno sfregio».
Ma eccola, tutto d’un tratto, la speranza. Nel luogo più vicino, eppure più impensabile. Nello stesso casolare che ospita la sua famiglia, soggiornano pure Cosma e Placida, rispettivamente madre e figlia. Quest’ultima, nonostante sia poco più che ventenne, è già vedova: suo marito è già stato inghiottito dalle prime fasi del conflitto. Il sentimento di Simone è vibrante, a tratti teneramente infantile. Ma certo anche totalizzante. E Placida, che per anni aveva conosciuto soltanto privazioni e massacranti faccende domestiche, ricambia. I due dolori giungono a combaciare e a curarsi l’un l’altro. Il dramma individuale – ma anche collettivo, della Storia – incontra l’istinto del riscatto. Il senso di colpa, la latente sindrome del sopravvissuto, lascia il posto, nel cuore di Simone, alla sorpresa, alla consapevolezza che i fiori possono crescere anche all’ombra delle bombe. Che qualcosa rimane più forte di ogni disperazione. Che si può amare anche, e soprattutto, quando ci si sente condannati.
E che forse, in fondo, l’unico modo di affrontare un male così inspiegabile, il desiderio così radicale che gli uomini covano di annientarsi a vicenda, è proprio questo. Intestardirsi ad amare. Sperare contro ogni probabilità. Restare puri, ingenui nella malizia generale. Ritagliarsi uno spazio di pietà e di illusione anche nel giorno più buio.
(Immagine in copertina realizzata con Bing Image Creator)