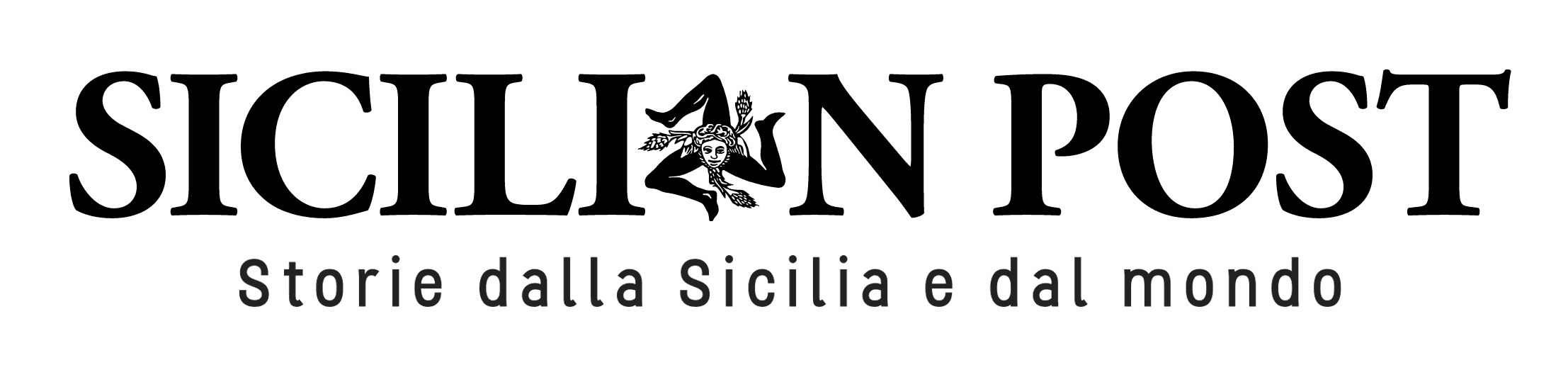Tra migrazioni e colonialismo: perché gli italiani hanno poca memoria
«Terra di partenze e di arrivi, la Sicilia con la sua identità multiforme è, nel nostro paese, la realtà più pronta a divenire terra di dialogo e di confronto costruttivo tra comunità che, alla base della loro storia, hanno una comune necessità di interagire con l’altro. Un esempio virtuoso di questa dinamica, e del potenziale che può sviluppare, è la convivenza armoniosa, a Mazara del Vallo, di comunità autoctone e tunisine». Nell’ambizioso volume che Teresa Fiore, docente alla Montclair State University, presenterà il 22 luglio all’Hub Isola presso Palazzo Biscari a Catania, la Sicilia è solo uno dei tasselli di un mosaico variegato. “Spazi pre-occupati: Una rimappatura delle migrazioni transnazionali e delle eredità coloniali italiane” riprende le fila della complessa questione migratoria nazionale, aggiungendo al dibattito prospettive ancora poco esplorate e includendo diversi contributi di carattere letterario. Ne abbiamo discusso a tu per tu con l’autrice.

A partire da immigrazione e colonialismo, il volume tratta di tematiche che spesso non trovano, purtroppo, molto spazio nel dibattito pubblico. Quale è stata, per lei, la molla che ha fatto scattare l’esigenza di mettere ordine sulle questioni?
«Si tratta di un interesse che risale a molti anni fa quando, trasferitami all’estero per i miei studi, ho acquisito la consapevolezza di essere una migrante. Anche il fenomeno dei cervelli in fuga, infatti, si può considerare migrazione a tutti gli effetti. La mia partenza risale al 1995, quando l’Italia si era ormai configurata stabilmente sia come punto di arrivo sia di partenza per flussi consistenti di migranti. Mi interessava, insomma, ricostruire questa compresenza di movimenti sia dall’esterno che dall’interno».
Come ben messo in evidenza nel volume, i fenomeni migratori non sono certamente una novità per il nostro paese. Nel corso della sua ricerca, ha individuato dei possibili fili conduttori alla base di questi spostamenti secolari?
«Innanzitutto, si parte ancora per ragioni economiche; in questo senso la molla di base rimane la stessa. Tuttavia, tra i paesi del G7 l’Italia, è un caso particolarissimo e pieno di contraddizioni: siamo un paese da cui si emigra più che altrove, pur restando contemporaneamente meta di immigrazione; ci confrontiamo con questioni razziali molto calde, ma non riusciamo a leggerle attraverso la nostra esperienza coloniale. Si parte anche per cercare nuove dimensioni personali: penso a persone la cui sessualità non trova piena espressione in Italia. Proprio al fine di risolvere queste contraddizioni, il mio libro guarda all’Italia come laboratorio in cui ripensare il nostro modo di sentirci parte di una comunità nazionale».
Ha toccato un punto cardine del presente e della nostra identità di italiani, che spesso si scontra con una logica dicotomica. Se siamo una terra di emigrati secolari, perché abbiamo resistenze verso chi cerca ciò che noi cerchiamo andando all’estero?
«Questa è l’altra molla del mio libro. La risposta è che soffriamo di una grave amnesia. Tutti, specialmente in Sicilia, hanno uno zio di Brooklyn, eppure non si rendono conto che al di là di questa sfera privata c’è una storia nazionale di diaspora di cui molti non immaginano le dimensioni. Il libro ha voluto organizzare questo materiale proprio per informare, per dare un contesto a storie familiari molto spesso piuttosto vaghe. Questa amnesia, cioè la mancanza di un discorso istituzionalizzato, tanto nei testi didattici quanto nei dibattiti pubblici, non ci ha permesso di misurarci adeguatamente con chi arriva oggi da noi. Ritengo sia una questione colpevolmente insoluta. Il libro cerca di riempire questo vuoto di conoscenza, di dati, date, luoghi e esperienza».
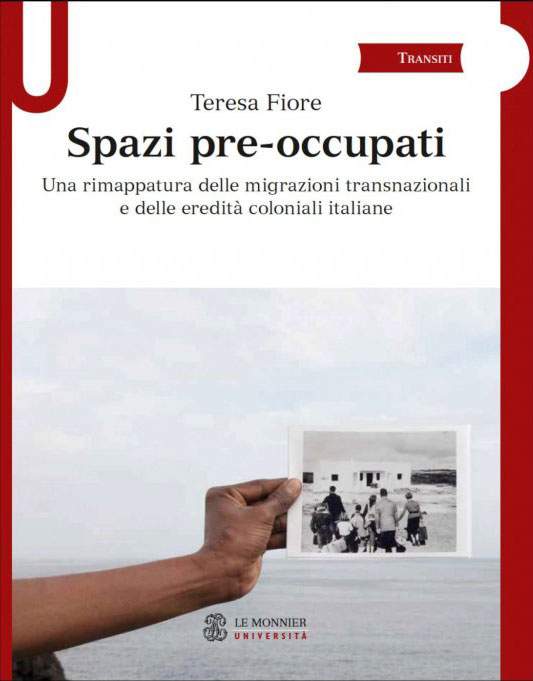
In che modo, nella ricostruzione del volume, si annodano la questione migratoria e quella coloniale?
«Sebbene in Italia se ne parli a stento, il nostro passato coloniale è iniziato proprio in coincidenza con l’unificazione. Allo stesso modo, anche emigrazione e colonialismo si sviluppano in contemporanea. Del tutto peculiare è stata la nostra abitudine a considerare i due fenomeni alla stessa stregua: sia la comunità italiana di San Francisco sia l’insediamento di Asmara erano entrambe “colonie”. E se il colonialismo in senso proprio è stato un fenomeno di breve durata, esso ha avuto gravi ripercussioni che arrivano fino ai giorni nostri. Perché se è vero che le comunità eritrea e somala non sono le più numerose in Italia, la nostra esperienza dovrebbe aiutarci a capire che anche chi arriva da quei paesi non è un invasore. Ad invadere, con buona pace del luogo comune degli italiani “brava gente”, siamo stati noi, spesso a suon di gas nervino (che per primi abbiamo usato contro i civili). La grande ironia è che noi quando siamo andati negli Usa siamo stati visti come neri. Siamo stati linciati alla fine dell’800 e abbiamo sostituito gli schiavi dopo l’abolizione della schiavitù».
Il libro si distingue per un approccio multidisciplinare nel quale trovano abbondante spazio riferimenti a cinema, teatro e letteratura. In che modo l’arte può aiutarci a superare l’amnesia a cui lei fa riferimento?
«Nonostante si appoggi ai risultati di sociologia, storia e statistica, al libro interessano principalmente le persone, e in particolare le storie umane così come sono state raccontate da scrittori e scrittrici, da registi e registe. Testimonianze preziose non solo per conoscere, ma anche per difenderci dai cliché. Mi auguro che il libro sia anche un’occasione per approfondire alcune delle opere a cui faccio riferimento nel testo».
Alla luce di questa complessità storica, considerando anche la nostra “ostilità” verso chi arriva, è possibile rispondere alla domanda: chi è l’italiano oggi?
«Di certo non in modo univoco. A me sembra interessante un concetto, come quello di Agamben, di comunità che viene. Credo che solo abituandoci ad un’italianità porosa e fluida, sempre in movimento, possiamo creare una comunità politicamente più sagace, più creativa, anziché fossilizzarci sul “prima gli italiani”».